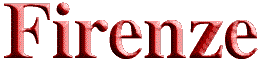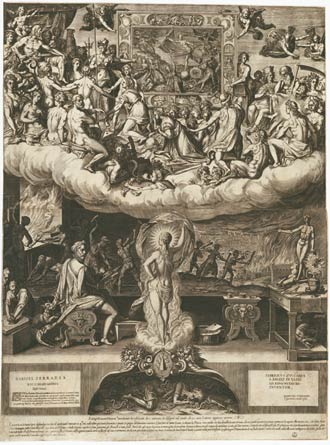"Prese Lionardo
a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di mona Lisa sua
moglie;
e quattro anni penatovi, lo lasciò imperfetto: la quale
opera oggi
è appresso il re Francesco di Francia in Fontanableò.
Nella qual testa, chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitar
la natura,
agevolmente si poteva comprendere, perchè quivi erano
contrafatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza
dipingnere: avvegnaché
gli occhi avevano qu' lustri e quelle acquitrine che di continuo
si veggono nel vivo, et intorno a essi erano tutti que' rossigni
lividi e i peli, che non senza grandissima sottigliezza si possono
fare; le ciglia, per avervi fatto il modo del nascere i peli
nella carne, dove più folti e dove più radi, e
girare secondo i pori della carne, non potevano essere più naturali;
il naso, con tutte quelle belle aperture rossette e tenere, si
vedeva
essere vivo; la bocca con quella sua sfenditura, con le sue fini
unite dal rosso della bocca con l'incarnazione del viso, che
non colori ma carne pareva veramente; nella fontanella della
gola,
che intentissimamente la guardava, vedeva battere i polsi: e
nel vero si può dire che questa fussi dipinta d'una maniera
da far
tremare e temere ogni gagliardo artefice, e sia qual si vuole".
Ma nel 1574, in Francia, un visitatore italiano
molto maldisposto verso il Vasari e tutti gli artisti fiorentini
lo vide e concepì un commento, che è certamente
- dopo quello vasariano - l'inizio della sterminata fortuna critica
del quadro,
qui per la verità in accezione negativa. Si tratta del
nostro Federico Zuccari che, recatosi in Francia al servizio
del cardinale
di Lorena nel 1574, visitò Fontainebleau, come dimostra
il suo giudizio (anch'esso severo) sulle pitture del Rosso Fiorentino
nella Galleria, definite "una porcaria" in una delle
polemiche postille alle Vite del Vasari. E oltre alla
Galleria, dovette vedere la Gioconda, poiché all'esaltazione
della "maniera" stupenda, "da far tremare e temere"
espressa dal Vasari a proposito di quel quadro, oppose in un'altra
postilla una valutazione riduttiva e risentita: "secha e di poco
gusto e da fugirla e non dar fine mai a cosa alcuna come fece
il ditto Lionardo che consumò la vita in sustanzie di parole
e ghiribizzi sufistichi e di poca utilita a se stesso e al arte".
La disapprovazione espressa in questo precocissimo
e sbalorditivo commento (che non riesce, ed è un peccato, a entrare
nella storia critica della Gioconda, forse per incomunicabilità
di ambiti bibliografici) aveva per bersaglio Leonardo da Vinci,
stigmatizzato per l'iconcludenza e le inclinazioni capricciose;
ma coinvolgeva anche il biografo Giorgio Vasari, reo di avere
maltrattato Taddeo Zuccari e posto al vertice del sistema delle
arti gli artisti toscani anzichè l'urbinate Raffaello, nelle
Vite del 1568.
I due non furono le uniche vittime della
ricorrente insofferenza dello Zuccari, che non esitò ad attaccare
di volta in volta colleghi e committenti, se riteneva di aver
subito dei torti. E se quasi sempre il suo garbo cortigiano lo
fece uscire indenne da questi scontri, una volta almeno il nostro
artista pagò caro il piacere di vendicarsi... La storia esemplare
della Porta Virtutis, che gli costò l'esilio. è il cardine di
questa mostra dedicata al genere figurativo quanto mai curioso,
e non tanto raro, delle "vendette d'artista" tra Rinascimento
e Barocco. |